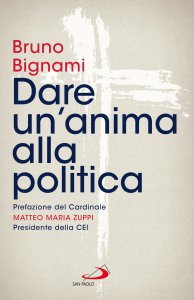Papa Francesco
58a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
58a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2025
Papa Francesco
In ascolto del grido dell’umanità minacciata.
All’alba di questo nuovo anno donatoci dal Padre celeste, tempo Giubilare dedicato alla speranza, rivolgo il mio più sincero augurio di pace ad ogni donna e uomo, in particolare a chi si sente prostrato dalla propria condizione esistenziale, condannato dai propri errori, schiacciato dal giudizio altrui e non riesce a scorgere più alcuna prospettiva per la propria vita. A tutti voi speranza e pace, perché questo è un Anno di Grazia, che proviene dal Cuore del Redentore!
Nel 2025 la Chiesa Cattolica celebra il Giubileo, evento che riempie i cuori di speranza. Il “giubileo” risale a un’antica tradizione giudaica, quando il suono di un corno di ariete (in ebraico yobel) ogni quarantanove anni ne annunciava uno di clemenza e liberazione per tutto il popolo (cfr Lv 25,10). Questo solenne appello doveva idealmente riecheggiare per tutto il mondo (cfr Lv 25,9), per ristabilire la giustizia di Dio in diversi ambiti della vita: nell’uso della terra, nel possesso dei beni, nella relazione con il prossimo, soprattutto nei confronti dei più poveri e di chi era caduto in disgrazia. Il suono del corno ricordava a tutto il popolo, a chi era ricco e a chi si era impoverito, che nessuna persona viene al mondo per essere oppressa: siamo fratelli e sorelle, figli dello stesso Padre, nati per essere liberi secondo la volontà del Signore (cfr Lv 25,17.25.43.46.55).
Anche oggi, il Giubileo è un evento che ci spinge a ricercare la giustizia liberante di Dio su tutta la terra. Al posto del corno, all’inizio di quest’Anno di Grazia, noi vorremmo metterci in ascolto del «grido disperato di aiuto» che, come la voce del sangue di Abele il giusto, si leva da più parti della terra (cfr Gen 4,10) e che Dio non smette mai di ascoltare. A nostra volta ci sentiamo chiamati a farci voce di tante situazioni di sfruttamento della terra e di oppressione del prossimo. Tali ingiustizie assumono a volte l’aspetto di quelle che S. Giovanni Paolo II definì «strutture di peccato», poiché non sono dovute soltanto all’iniquità di alcuni, ma si sono per così dire consolidate e si reggono su una complicità estesa.
Ciascuno di noi deve sentirsi in qualche modo responsabile della devastazione a cui è sottoposta la nostra casa comune, a partire da quelle azioni che, anche solo indirettamente, alimentano i conflitti che stanno flagellando l’umanità. Si fomentano e si intrecciano, così, sfide sistemiche, distinte ma interconnesse, che affliggono il nostro pianeta. Mi riferisco, in particolare, alle disparità di ogni sorta, al trattamento disumano riservato alle persone migranti, al degrado ambientale, alla confusione colpevolmente generata dalla disinformazione, al rigetto di ogni tipo di dialogo, ai cospicui finanziamenti dell’industria militare. Sono tutti fattori di una concreta minaccia per l’esistenza dell’intera umanità. All’inizio di quest’anno, pertanto, vogliamo metterci in ascolto di questo grido dell’umanità per sentirci chiamati, tutti, insieme e personalmente, a rompere le catene dell’ingiustizia per proclamare la giustizia di Dio. Non potrà bastare qualche episodico atto di filantropia. Occorrono, invece, cambiamenti culturali e strutturali, perché avvenga anche un cambiamento duraturo.
Un cambiamento culturale: siamo tutti debitori
L’evento giubilare ci invita a intraprendere diversi cambiamenti, per affrontare l’attuale condizione di ingiustizia e diseguaglianza, ricordandoci che i beni della terra sono destinati non solo ad alcuni privilegiati, ma a tutti. Può essere utile ricordare quanto scriveva S. Basilio di Cesarea: «Ma quali cose, dimmi, sono tue? Da dove le hai prese per inserirle nella tua vita? […] Non sei uscito totalmente nudo dal ventre di tua madre? Non ritornerai, di nuovo, nudo nella terra? Da dove ti proviene quello che hai adesso? Se tu dicessi che ti deriva dal caso, negheresti Dio, non riconoscendo il Creatore e non saresti riconoscente al Donatore». Quando la gratitudine viene meno, l’uomo non riconosce più i doni di Dio. Nella sua misericordia infinita, però, il Signore non abbandona gli uomini che peccano contro di Lui: conferma piuttosto il dono della vita con il perdono della salvezza, offerto a tutti mediante Gesù Cristo. Perciò, insegnandoci il “Padre nostro”, Gesù ci invita a chiedere: «Rimetti a noi i nostri debiti» ( Mt 6,12).
Quando una persona ignora il proprio legame con il Padre, incomincia a covare il pensiero che le relazioni con gli altri possano essere governate da una logica di sfruttamento, dove il più forte pretende di avere il diritto di prevaricare sul più debole. Come le élites ai tempi di Gesù, che approfittavano delle sofferenze dei più poveri, così oggi nel villaggio globale interconnesso, il sistema internazionale, se non è alimentato da logiche di solidarietà e di interdipendenza, genera ingiustizie, esacerbate dalla corruzione, che intrappolano i Paesi poveri. La logica dello sfruttamento del debitore descrive sinteticamente anche l’attuale “crisi del debito”, che affligge diversi Paesi, soprattutto del Sud del mondo.
Non mi stanco di ripetere che il debito estero è diventato uno strumento di controllo, attraverso il quale alcuni governi e istituzioni finanziarie private dei Paesi più ricchi non si fanno scrupolo di sfruttare in modo indiscriminato le risorse umane e naturali dei Paesi più poveri, pur di soddisfare le esigenze dei propri mercati. A ciò si aggiunga che diverse popolazioni, già gravate dal debito internazionale, si trovano costrette a portare anche il peso del debito ecologico dei Paesi più sviluppati. Il debito ecologico e il debito estero sono due facce di una stessa medaglia, di questa logica di sfruttamento, che culmina nella crisi del debito. Prendendo spunto da quest’anno giubilare, invito la comunità internazionale a intraprendere azioni di condono del debito estero, riconoscendo l’esistenza di un debito ecologico tra il Nord e il Sud del mondo. È un appello alla solidarietà, ma soprattutto alla giustizia.
Il cambiamento culturale e strutturale per superare questa crisi avverrà quando ci riconosceremo finalmente tutti figli del Padre e, davanti a Lui, ci confesseremo tutti debitori, ma anche tutti necessari l’uno all’altro, secondo una logica di responsabilità condivisa e diversificata. Potremo scoprire «una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri».
III. Un cammino di speranza: tre azioni possibili
Se ci lasciamo toccare il cuore da questi cambiamenti necessari, l’Anno di Grazia del Giubileo potrà riaprire la via della speranza per ciascuno di noi. La speranza nasce dall’esperienza della misericordia di Dio, che è sempre illimitata.
Dio, che non deve nulla a nessuno, continua a elargire senza sosta grazia e misericordia a tutti gli uomini. Isacco di Ninive, un Padre della Chiesa orientale del VII secolo, scriveva: «Il tuo amore è più grande dei miei debiti. Poca cosa sono le onde del mare rispetto al numero dei miei peccati, ma se pesiamo i miei peccati, in confronto al tuo amore, svaniscono come un nulla». Dio non calcola il male commesso dall’uomo, ma è immensamente «ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato» ( Ef 2,4). Al tempo stesso, ascolta il grido dei poveri e della terra. Basterebbe fermarsi un attimo, all’inizio di quest’anno, e pensare alla grazia con cui ogni volta perdona i nostri peccati e condona ogni nostro debito, perché il nostro cuore sia inondato dalla speranza e dalla pace.
Gesù, per questo, nella preghiera del “Padre nostro”, pone l’affermazione molto esigente «come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» dopo che abbiamo chiesto al Padre la remissione dei nostri debiti (cfr Mt 6,12). Per rimettere un debito agli altri e dare loro speranza occorre, infatti, che la propria vita sia piena di quella stessa speranza che giunge dalla misericordia di Dio. La speranza è sovrabbondante nella generosità, priva di calcoli, non fa i conti in tasca ai debitori, non si preoccupa del proprio guadagno, ma ha di mira solo uno scopo: rialzare chi è caduto, fasciare i cuori spezzati, liberare da ogni forma di schiavitù.
Vorrei, pertanto, all’inizio di quest’Anno di Grazia, suggerire tre azioni che possano ridare dignità alla vita di intere popolazioni e rimetterle in cammino sulla via della speranza, affinché si superi la crisi del debito e tutti possano ritornare a riconoscersi debitori perdonati.
Anzitutto, riprendo l’appello lanciato da S. Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo dell’anno 2000, di pensare a una «consistente riduzione, se non proprio al totale condono, del debito internazionale, che pesa sul destino di molte Nazioni». Riconoscendo il debito ecologico, i Paesi più benestanti si sentano chiamati a far di tutto per condonare i debiti di quei Paesi che non sono nella condizione di ripagare quanto devono. Certamente, perché non si tratti di un atto isolato di beneficenza, che rischia poi di innescare nuovamente un circolo vizioso di finanziamento-debito, occorre, nello stesso tempo, lo sviluppo di una nuova architettura finanziaria, che porti alla creazione di una Carta finanziaria globale, fondata sulla solidarietà e sull’armonia tra i popoli.
Inoltre, chiedo un impegno fermo a promuovere il rispetto della dignità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, perché ogni persona possa amare la propria vita e guardare con speranza al futuro, desiderando lo sviluppo e la felicità per sé e per i propri figli. Senza speranza nella vita, infatti, è difficile che sorga nel cuore dei più giovani il desiderio di generare altre vite. Qui, in particolare, vorrei ancora una volta invitare a un gesto concreto che possa favorire la cultura della vita. Mi riferisco all’eliminazione della pena di morte in tutte le Nazioni. Questo provvedimento, infatti, oltre a compromettere l’inviolabilità della vita, annienta ogni speranza umana di perdono e di rinnovamento.
Oso anche rilanciare un altro appello, richiamandomi a S. Paolo VI e a Benedetto XVI, per le giovani generazioni, in questo tempo segnato dalle guerre: utilizziamo almeno una percentuale fissa del denaro impiegato negli armamenti per la costituzione di un Fondo mondiale che elimini definitivamente la fame e faciliti nei Paesi più poveri attività educative e volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, contrastando il cambiamento climatico. Dovremmo cercare di eliminare ogni pretesto che possa spingere i giovani a immaginare il proprio futuro senza speranza, oppure come attesa di vendicare il sangue dei propri cari. Il futuro è un dono per andare oltre gli errori del passato, per costruire nuovi cammini di pace.
La meta della pace
Coloro che intraprenderanno, attraverso i gesti suggeriti, il cammino della speranza potranno vedere sempre più vicina la tanto agognata meta della pace. Il Salmista ci conferma in questa promessa: quando «amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno» ( Sal 85,11). Quando mi spoglio dell’arma del credito e ridono la via della speranza a una sorella o a un fratello, contribuisco al ristabilimento della giustizia di Dio su questa terra e mi incammino con quella persona verso la meta della pace. Come diceva S. Giovanni XXIII, la vera pace potrà nascere solo da un cuore disarmato dall’ansia e dalla paura della guerra.
Che il 2025 sia un anno in cui cresca la pace! Quella pace vera e duratura, che non si ferma ai cavilli dei contratti o ai tavoli dei compromessi umani. Cerchiamo la pace vera, che viene donata da Dio a un cuore disarmato: un cuore che non si impunta a calcolare ciò che è mio e ciò che è tuo; un cuore che scioglie l’egoismo nella prontezza ad andare incontro agli altri; un cuore che non esita a riconoscersi debitore nei confronti di Dio e per questo è pronto a rimettere i debiti che opprimono il prossimo; un cuore che supera lo sconforto per il futuro con la speranza che ogni persona è una risorsa per questo mondo.
Il disarmo del cuore è un gesto che coinvolge tutti, dai primi agli ultimi, dai piccoli ai grandi, dai ricchi ai poveri. A volte, basta qualcosa di semplice come «un sorriso, un gesto di amicizia, uno sguardo fraterno, un ascolto sincero, un servizio gratuito». Con questi piccoli- grandi gesti, ci avviciniamo alla meta della pace e vi arriveremo più in fretta, quanto più, lungo il cammino accanto ai fratelli e sorelle ritrovati, ci scopriremo già cambiati rispetto a come eravamo partiti. Infatti, la pace non giunge solo con la fine della guerra, ma con l’inizio di un nuovo mondo, un mondo in cui ci scopriamo diversi, più uniti e più fratelli rispetto a quanto avremmo immaginato.
Concedici, la tua pace, Signore! È questa la preghiera che elevo a Dio, mentre rivolgo gli auguri per il nuovo anno ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle Organizzazioni internazionali, ai Leader delle diverse religioni, ad ogni persona di buona volontà.
Rimetti a noi i nostri debiti, Signore, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e in questo circolo di perdono concedici la tua pace,
quella pace che solo Tu puoi donare a chi si lascia disarmare il cuore,
a chi con speranza vuole rimettere i debiti ai propri fratelli,
a chi senza timore confessa di essere tuo debitore,
a chi non resta sordo al grido dei più poveri.