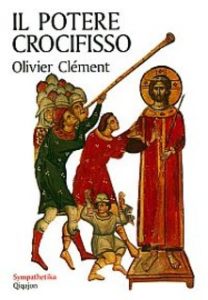 IL POTERE E LA FEDE: LA PERSONA NELLA SOCIETÀ
IL POTERE E LA FEDE: LA PERSONA NELLA SOCIETÀ
Estratto da Il potere crocifisso di Olivier Clément[1]
EDIZIONI QIQAJON- COMUNITÀ DI BOSE
Cercherò ora di parlare della relazione tra il potere e la fede. Dapprima mi chiederò cosa significhino queste due parole. Poi insisterò sull’apporto originale del cristianesimo. Infine, porrò la domanda su come, anche oggi, un cristiano possa tentare di esercitare e la critica e la pratica del potere.
Quale potere, e quale fede?
Ogni uomo, per il fatto stesso della sua esistenza, detiene un potere, è potere. Ogni uomo si afferma di fronte al nulla e di fronte all’ altro. In virtù del suo essere stesso, egli esercita un’azione sul suo ambiente e sul mondo.
Il racconto simbolico delle origini, nella Genesi, sottolinea questo potere: “Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, … e domini…” (Gen 1,26). “Dio creò l’uomo a sua immagine … maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: … riempite la terra, soggiogatela e dominate…” (Gen 1,27 – 2 8). Il vocabolario della sovranità non dev’essere interpretato qui nella prospettiva della nostra caduta, cioè di una violenza distruttrice, ma una prospettiva “eucaristica”, di trasfigurazione. In quel dono di un potere creatore risiede la somiglianza originaria dell’uomo con Dio. Una forza buona, vivificante, gli viene offerta. La paternità-maternità che assicura al bambino gli apprendimenti indispensabili – e innanzi tutto quello del linguaggio -, tra l’ascesi e la tenerezza, la distanza e la vicinanza; il potere nella società, per assicurare un minimo d’ordine e di pace, che permetterà la trasmissione di una cultura, di una memoria, e dunque la volontà di un avvenire comune; la conoscenza e la creatività come tensione alla bellezza e alla spiritualizzazione del mondo… tutto questo è potere, sovranità dell’essere, come il libero slancio di un cavallo o la forte stabilità di un albero. Con in più, nell’uomo, la coscienza e il linguaggio, il linguaggio come apertura della coscienza, capacità di fare del mondo un’offerta e una condivisione, un dialogo degli uomini tra di loro e con Dio.
Ma sappiamo bene che c’è anche, come qualcosa che misteriosamente precede le nostre scelte, il mistero del male. C’è il peccato come distruzione originale e permanente del rapporto ancora più originale d’amore con Dio. Allora sopraggiunge l’orgoglio di possedere se stessi, e la potenza buona dell’essere è parzialmente vampirizzata dalla sete di dominio e di oppressione dell’altro. Separato da Dio, dunque votato alla morte, l’uomo cerca di dimenticare la sua precarietà esercitando il dominio. Egli ha bisogno di schiavi per credersi dio, cioè immortale, lui che è schiavo della morte. Nel De civitate Dei Agostino ha sviluppato questa dialettica tra l’impotenza segreta e la violenza ostentata.
Bisogno di schiavi, bisogno dunque di nemici. René Girard ha mostrato come, nella maggior parte delle società, la violenza, che mina quando addirittura non impedisce la vita comune, sia respinta alle frontiere, esorcizzata con la messa a morte del capro espiatorio. L’uomo proietta la sua angoscia sull’altro e lo uccide per uccidere la propria angoscia.
Il potere, originariamente di vita, diventa così potere di morte. Fino a oggi, fino alla “monarchia atomica” del presidente della repubblica francese, la stessa definizione di potere è proprio di questo tipo: la capacità di dare la morte. Una sorta di sacralità circonda quindi il potere. “Anche un semplice agente di polizia suscita sentimenti diversi rispetto a un normale uomo in giacca” – o in jeans -, notava Nikolaj Berdjaev. E per lui l’esercizio del potere decaduto, potere di violenza e di dominio, è legato a una specie d’ipnosi nelle masse…
Nel mondo precristiano, la divinizzazione del potere si realizzava apertamente. Si pensi all’ apoteosi dell’imperatore romano, dichiarato Divus e Pontifex maximus. Il potere che si divinizza e vuole farsi adorare è idolatrico: è la denuncia costante della Bibbia, da Nabucodonosor alla bestia dell’ Apocalisse, che allude al culto di Cesare e della dea Roma. Idolatria alla quale la modernità si è riaffacciata a partire dalla concezione hegeliana, comunemente diffusa, della manifestazione dello Spirito assoluto nella storia come divenire collettivo, manifestazione che si è pienamente incarnata nei totalitarismi del nostro secolo.
Ora, per il Nuovo Testamento e per san Paolo in particolare, le potenze demoniache sono invisibilmente ma molto realmente presenti sullo sfondo della storia. I “dominatori di questo mondo” (1Cor 2,8) non sono soltanto i sovrani terreni ma quegli angeli ambigui o chiaramente decaduti che fanno del potere idolatrico una vera possessione.
Ormai abbiamo in mano gli anelli della catena:
– la vertigine della morte e il potere di dare la morte;
– il bisogno di schiavi e di nemici;
– l’esercizio sulle masse di una sorta d’ipnosi e di possessione magica con un potere i cui stessi detentori sono dei posseduti (l’ultimo anello si ricollega al primo).
E tutto questo si mescola con la potenza buona dell’essere, catturandone e deviandone l’energia senza però giungere a sopprimerla, perché l’uomo resta a immagine di Dio ed è proprio il dinamismo dell’immagine che, deviato, suscita il desiderio di auto-deificazione, di auto-idolatria. Il potere è così nel contempo il riflesso dell’assoluto e la sua caricatura, la sua usurpazione demoniaca.
Una simile deformazione coesiste con una deformazione simmetrica della fede. Nelle società arcaiche, comprese, fino ai rivolgimenti contemporanei, l’India e la Cina, la fede, gravitante sull’interiorità impersonale, cementa culture che vogliono restare immobili, che si fissano in gerarchie e caste, e fanno sentire inferiori o addirittura espellono i devianti. La storia non è arricchita, ma è negata, ridotta a un processo di degradazione dove sarebbero possibili solo delle “restaurazioni” sempre più problematiche. L’interiorità buddhista in particolare è una voragine nella quale culture intere sono state inghiottite…
Completamente diversa è la rivelazione biblica, semitica, del Dio personale, che alimenta, sino a oggi, il dinamismo della storia universale. Nella misura in cui ignora – oppure dimentica – la distinzione tra regno di Dio e regno di Cesare, essa scatena, attraverso la fede, una violenza conquistatrice: sia per assicurare la “terra promessa” al “popolo eletto”, sia per imporre la verità agli infedeli. Islam e cristianità si sono affrontati in preda alla stessa confusione. La violenza dell’occidente, o della Russia, ha troppo sovente appoggiato la missione cristiana.
La secolarizzazione della fede in ideologia nazionalista, nel XX secolo, esaspera ancora di più questa violenza distruttrice. Giacché la fede, quando degenera in semplice appartenenza, quando si lega al desiderio di semplificazione per questo stesso fatto non è più altro che fanatismo. Per questo oggi così spesso la si teme: la cristianità ha lasciato il ricordo dell’Inquisizione, le ideologie totalitarie quello dei campi di sterminio, il risveglio dell’Islam non avviene senza aggressività, il sionismo di destra si mostra ciecamente conquistatore, i nazionalismi religiosi, specie nel mondo ortodosso, sono i più temibili.
La rivoluzione di Cristo.
La fede della quale vorrei ora parlare è la fede evangelica, la fede propriamente cristiana. Adesione personale a una presenza personale velata-svelata: quella del Dio misterioso, inaccessibile, che si rivela, si dona, si rende partecipabile in Gesù Cristo, senza perdere per questo il suo mistero. L’insegnamento evangelico, distinguendo il regno di Dio e il regno di Cesare, apre lo spazio della libertà dello spirito, della libertà della persona. Il regno di Cesare è insieme desacralizzato, delimitato e orientato. Legittimo nel suo ordine, è illegittimo quando pretende di farsi adorare, quando si presenta come una realtà totalizzante, pseudo-divina. Quanto al regno di Dio, “esso non è di questo mondo”, non si manifesta secondo le modalità di questo mondo, secondo il suo potere di morte. Tuttavia misteriosamente, sacramentalmente, trasformando i cuori (cioè, nel linguaggio biblico, le intelligenze), esso feconda il mondo in quanto creazione di Dio, mentre lo contesta e lo mina in quanto rete d’illusioni, di menzogne e di seduzioni.
Nella prospettiva evangelica, il vero potere è quello del Dio crocifisso: un potere che vuole l’alterità dell’ altro fino a lasciarsi uccidere per offrirgli la risurrezione. Perciò il potere assoluto – quello di Dio, del Pantokrator -, s’identifica con l’assoluto del dono di sé, con il sacrificio che comunica la vita agli uomini e fonda la loro libertà. Il Dio incarnato è “colui che dona la propria vita per i suoi amici” e prega per i suoi carnefici.
Il potere di Dio significa il potere dell’ amore. Per “follia d’amore”, colui che è la Vita in pienezza diventa per noi la vita al cuore della morte. “Ho il potere di offrirla (la mia vita) e il potere di riprenderla di nuovo” (Gv 10,18), dice Gesù. Di questo paradosso divino che trascende le antinomie della creazione decaduta, quella della vita e della morte, della consegna di sé e dell’ affermazione di sé, di questo paradosso che è il paradosso stesso dell’ amore, casi debole nella sua sovranità, casi sovrano nella sua debolezza, noi troviamo un’espressione mirabile, fortemente messa in risalto, in Paolo: “È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione … perché… ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini … Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti” (1Cor 1,21-28).
La kenosi, lo svuotamento volontario del Dio incarnato, rivela la vita stessa della Trinità. Quando Giovanni, nel prologo del suo evangelo, ci parla del Verbo pròs tòn Theon, rivolto verso il Padre, ci mostra un Dio che si apre, un Dio nel quale l’Uno non esiste senza l’Altro, nel sacrificio gioioso di ciascuno perché l’altro esista. Un Dio che si apre, un Dio che si dona: il fatto che il potere di Dio sia quello dell’amore implica una limitazione volontaria che Dio s’impone per dare all’uomo (e all’angelo) uno spazio per la sua libertà. O piuttosto, è in questa limitazione che risiede l’autentica onnipotenza, che si esprime il mistero di Dio come dono di sé, umiltà, rispetto dell’altro fino alla croce: “L’Agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo” (cf. Ap 5,6; 13,8).
Per questo il mistero della debolezza di Dio è quello della sua autentica onnipotenza: mistero messo in luce con la vita, la passione e la croce di Gesù, mistero nascosto nell’ essenza profonda della chiesa, nell’ esistenza crocifissa dei santi.
Nel corso degli attacchi che dovette subire, Gesù fu sicuramente tentato nella sua piena umanità, assunta nel contesto di un popolo e di un’epoca ossessionati da un messianismo combattivo, di prendere di persona il potere per le vie della violenza. Fu l’ultima seduzione che egli respinse nel deserto. In Galilea, era circondato da un potente movimento popolare che voleva “venire a prenderlo per farlo re” (Gv 6,15). Fu allora che decise di concentrarsi sul “piccolo gregge” dei suoi discepoli, e di andare a portare la lotta al cuore stesso del potere: a Gerusalemme, sede del potere religioso ebraico, che si serviva di Dio per asservire l’uomo, e sede del potere politico romano, che asserviva l’uomo per farsi Dio. Allora ci furono la croce, la risurrezione, la pentecoste, l’effondersi della grazia come forza semplicemente buona, vivificante, al di là delle ambivalenze del mondo decaduto in cui non c’è mai vita senza morte, amore senza odio, forza senza violenza…
In Cristo, sotto l’influsso dello Spirito, siamo chiamati a partecipare a questa forza, a questo potere sacrificale e salvifico. “A quanti l’hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). Il “se tu puoi qualcosa” del padre disperato provoca la risposta: “Tutto è possibile per chi crede” (Mc 9,22-23). Né l’uomo senza Dio, né Dio senza l’uomo: in Cristo non vi è separazione né confusione tra di loro. Per questo al “senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5) di Cristo corrisponde il grido di giubilo di Paolo: “Tutto posso in colui (Cristo) che mi dà la forza” (Fil4,13). E ancora, leggiamo nell’ evangelo: “Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò” (Gv 14,13). “Se avrete fede pari a un granellino di senapa … niente vi sarà impossibile” (M t 17,20).
Alla dialettica tra l’impotenza e la violenza subentra la dialettica tra la debolezza e la forza: in Cristo, l’uomo ritrova la sua vocazione di creatore creato, teso alla manifestazione del regno già segretamente presente. “La mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza” (2Cor 12,9).
L’uomo che s’identifica al crocifisso, riceve la forza del risorto: “lo mi compiaccio negli oltraggi, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). Nella tradizione degli anawim, e più in particolare di Amos, di Geremia, di molti salmi, i “miti”, i “poveri”, gli “umili” dell’Antico Testamento sono chiamati “beati” nelle Beatitudini, perché fanno posto a Dio in se stessi, perché offrono uno spazio allo Spirito santo. Per questo Maria, nel suo cantico di lode, celebra gli “umili”, quelli che si sono svuotati per Dio, aperti a Dio, e che egli ha potuto innalzare proprio mentre rovescia i “potenti” dai loro troni, troppo appesantiti e troppo pieni di sé, troppo ricchi, nei quali egli non può trovare spazio.
Il potere di Cristo, potere della fede e dell’umiltà, si esprime come servizio. Il testo decisivo, su questo punto, è quello di Lc 22,25-27: «Egli disse: “I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande fra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve”».
Il potere “che serve” diventa, nel senso etimologico della parola, autorità; auctoritas viene dal verbo augere che significa far maturare, far crescere. Cercare di sottomettersi a ogni vita per farla crescere in pienezza.
La vittoria di Cristo sulla morte trasforma al fondo del nostro essere l’angoscia in gratitudine. I padri della chiesa, specie i padri ascetici, rivelano che le due “passioni-madre” sono l’avidità e l’orgoglio, queste risorse del potere decaduto, e più in profondità ancora, “la paura nascosta della morte”. Ma se siamo veramente risuscitati nel Risorto, se la morte è già alle nostre spalle, sepolta nelle acque del battesimo, allora non abbiamo più bisogno né di schiavi né di nemici per proiettare su di loro la nostra angoscia e il nostro desiderio di essere Dio: Dio, noi lo siamo umilmente in Cristo, siamo cioè capaci di amare.
Perciò ci viene manifestata tutta l’importanza del comando evangelico di amare i nostri nemici: «Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano…Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell’ Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6,27.35-36).
Si tratta di spezzare il circolo infernale dell’aggressione e della vendetta che, a sua volta, provoca una nuova aggressione più violenta, e via di seguito. Gesù non si è accontentato di assumere questo atteggiamento: egli ci ha resi capaci di farlo nostro grazie alla sua croce, alla sua risurrezione e al dono dello Spirito. Mediante la grazia della croce infatti, anche il fallimento, anche la morte possono far nascere il regno.
Esercitare il potere della fede?
Oggi i cristiani sono ovunque minoritari e non possono pretendere di guidare la società. L’ideale – raramente realizzato nella storia – del “santo principe”, del “re cristiano” che monopolizzava il sacerdozio regale del popolo di Dio, che accettava la chiesa come limite interiore e ispirazione del suo potere, infine e soprattutto, se ce ne fosse stato bisogno, che “donava la vita per i suoi amici”, questo ideale appartiene a una simbologia che ha esaurito il suo compito. O piuttosto deve essere interiorizzato, assunto da ogni cristiano, la cui vocazione è quella di essere “re, sacerdote e profeta” (cf. l Pt 2,9). lo cercherò d’individuare qui tre itinerari di servizio e d’impegno.
Comunicando al corpo “donato” da Gesù, al suo sangue “versato”, i cristiani devono mettersi in sintonia con le sue esigenze e il suo esempio profetico. Ormai il rifiuto del dominio diventa un segno distintivo della loro appartenenza a Cristo. È al cuore del pasto eucaristico che Luca pone la discussione tra i discepoli per sapere “chi è il più grande” (cf. Lc 22,24-27). Infatti il pasto eucaristico ha proprio lo scopo di suscitare tra i discepoli una nuova prassi, opposta a questo gioco d’ambizioni. Non èla grandezza quello che Gesù rifiuta, qualsiasi masochismo sarebbe di troppo. Ma: “Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo” (Mt 20,26). La vera grandezza non è nel dominare, ma nel servire.
La comunità eucaristica deve testimoniare – tentare di testimoniare -, in tutti gli ambiti questo spirito di servizio e questo rifiuto del dominio diventando, nella nostra epoca, in Europa occidentale, a misura d’uomo e permettendo una vera convivialità.
Questo implica uno stile particolare delle relazioni interne in seno all’istituzione ecclesiale. I poteri conferiti a certe funzioni ministeriali sono altrettante ri-proposizioni del potere di Cristo, che è il potere dell’ amore. “Pascete il gregge di Dio che vi è affidato… non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge” (IPt 5,1-3). In seno alla comunione prende così forma una paternità sacrificale e liberatrice, capace di orientare risolutamente senza umiliare, ma con l’intento di far crescere diffondendo lo Spirito, facendo circolare la vita. Un segno per il mondo, un modello altro: “Per voi, non è così”. Fondata sull’ offerta, la comunità eucaristica dovrebbe conoscere la vanità del possesso, l’alienazione del desiderio attraverso l’avere, attraverso la moltiplicazione dei bisogni.
Chi ci darà delle comunità nelle quali nel distacco (che si traduce concretamente nel rifiuto della corsa ai beni e al prestigio, nella semplicità e nella frugalità dell’esistenza) s’irradia la gioia dell’incontro, incontro di Dio e – cosa che ne è il segno e la posta in gioco incontro dei fratelli? … Questa gioia sarà, per tutti quelli che sono ingannati dalle fallaci promesse di una società fondata sulla modalità dell’ avere, un interrogativo su se stessi e sulla verità del loro desiderio, 1’appello a una metanoia – una conversione – liberatrice[2].
Uno stile simile esige da ciascuno un’ascesi insieme di distacco e di simpatia, il che suppone la presenza, non ai margini ma al cuore stesso della chiesa, di gente che rinuncia, di monaci che, con la loro povertà e umiltà volontarie, lascino spazio alla forza buona della grazia e assicurino ai credenti quei padri o quelle madri spirituali che testimoniano della paternità materna di Dio e ne trasmettono il Soffio. I cristiani che rinunciano anticipano il “mondo a rovescio” delle Beatitudini.
È importante che ogni comunità cristiana – una parrocchia, un movimento, un monastero – sia un luogo di condivisione discreta ma efficace a favore dei più abbandonati, credenti o non credenti poco importa, nell’ambito della città, del quartiere, della relazione stabilita con un certo settore particolarmente provato dei paesi dell’est o del terzo mondo.
In Russia, oggi, le iniziative sono numerose in questo campo. È certamente più difficile per le nostre piccole comunità ortodosse della diaspora, la misura non è la stessa, spesso si rende necessaria la collaborazione ecumenica. In ogni modo dobbiamo inventare, aprire gli occhi su una miseria crescente, offrire, anche poveramente. Ci è necessario, e già alcuni lo fanno, ritrovare quel legame tra il “sacramento dell’altare” e il “sacramento del fratello”, del quale parlava Giovanni Crisostomo. Non si tratta di sostituire il sacramentale con il sociale, il che porterebbe a fare del cristianesimo una variante sentimentale dell’umanitarismo, ma di mostrare il carattere sacramentale del sociale, della diaconia, e di fondare nella comunione ecclesiale questo istinto di solidarietà, cosi forte presso molti dei nostri contemporanei, soprattutto tra i giovani.
Collocare il politico nel giusto ambito è riconoscerne la necessità e insieme la relatività. La logica totalitaria identificava il potere con l’assoluto, il potere con un sapere che negasse ogni autonomia del politico. La logica liberale comporta, di fatto, l’identificazione quasi assoluta del potere con il denaro. Da qui nascono gli innumerevoli scandali che scuotono le nostre società e squalificano i responsabili politici. Invece di riproporre il luogo comune della politica come alienazione, del potere come fatalmente oppressivo, il nostro compito è quello di ripensare il politico, rifondare il potere politico nel suo obiettivo autentico: garantire le libertà e ostacolare la violenza distruttiva. Vladimir Soloviev diceva che il ruolo del potere non è quello di trasformare la società in un paradiso, ma di evitare che essa diventi un inferno. Vorrei citare qui due pensatori francesi contemporanei, entrambi cristiani: un economista, François Perroux, e un filosofo, Claude Bruaire. François Perroux, in Pouvoir et économie, scriveva: “La politica inizia nel punto in cui la violenza cessa”. Lo stato ha il compito di preservare, in determinate condizioni storiche, la vita e la libertà di ogni essere umano e di preconizzare un potere politico” distante dai singoli interessi, capace di orientarli e/o di fare da arbitro tra di loro”. A questo arbitro sono affidati gli obiettivi e i mezzi che non possono essere semplicemente contabilizzati, “ciò che, di conseguenza, non può avere mercato. È esso (lo stato) che, nella sua sfera, protegge gli uomini dall’invasione del mercato, li mette in condizioni favorevoli per resistere alla ‘mercificazione’ dell’ essere umano”[3].
Claude Bruaire, in La raison politique, individuava il ruolo del politico nello scongiurare la violenza, nella misura in cui esso dà diritto e forza alla giustizia e alla libertà. “Voler abolire ogni forma di potere politico è disprezzare la libertà per instaurare la violenza, assicurandole il dominio”. Il politico non si definisce dunque da ciò che è, ma dai legami che instaura, dai valori che salvaguarda. Non compete al potere politico esprimere un sapere assoluto, creare una religione o dei sindacati, ma permettere la libertà dello spirito, l’osservanza religiosa e l’esercizio dei diritti sindacali. Compito del suffragio universale non è opprimere la minoranza. Ogni minoranza deve essere protetta dal potere e ogni opposizione legale non soltanto legittimata ma favorita per permettere la critica e il dialogo. Si delinea cos1 l’ideale, sempre da difendere, sempre da reinventare, dello stato di diritto nel quale, diceva Bruaire, “la legge, ed essa sola, permette al potere di essere simultaneamente interno ed esterno alla società”[4] della quale è arbitro, e senza il libero consenso della quale non sarebbe nulla.
Collocare il potere nel giusto ambito significa dunque contemporaneamente delimitarlo e ispirarlo. Il suo limite “esterno” (a proposito del quale si può parlare di “contro-poteri”) non può essere che una società civile solida, nella quale si moltiplicano comunità e associazioni autonome, dove la famiglia è incoraggiata e salvaguardata. Il suo limite “interno” potrebbe essere invece 1’esistenza di un’etica testimoniata da una, o diverse, élite di irradiamento, prive di potere concreto, ma forti di una vera autorevolezza. Con il crollo delle ideologie e dei miti, mi sembra che stiano emergendo alcune tematiche fondamentali: quella della persona irriducibile, chiave di volta inoggettivabile, non concettualizzabile, di una moltitudine di approcci, tutti necessari; ad esempio l’ homo oeconomicus, ma anche l’homo ludens e l’homo adorans. Un’ altra tematica, con la scomparsa della civiltà contadina, è quella di un atteggiamento positivo, ormai cosciente e volontario, nei confronti della natura. O ancora il rispetto incondizionato della persona e delle complesse relazioni tra le persone costituite dalle lingue, dalle nazioni, dalle culture; un nuovo patto nuziale con la terra; la nascita di un’umanità europea e di un’umanità planetaria, non con la cancellazione, ma con la salvaguardia della loro diversità: questi sono ormai i nostri valori e i nostri compiti.
In quest’ambito si colloca, come si può facilmente intuire, il ruolo indispensabile del cristiano come “sentinella” – in conseguenza del quale il potere della fede può manifestarsi come “contro-potere” -, ma anche come “ispiratore”, e il potere della fede può manifestarsi allora come profezia. La chiesa, o il “consiglio delle chiese”, a seconda dei tempi e dei luoghi, è chiamata a diventare a suo rischio, con umiltà e fermezza, la coscienza della società. Coscienza che propone senza imporre, a rischio di un’emarginazione manifesta, quando non addirittura di una persecuzione, più o meno scoperta. Solo la coscienza cristiana può far emergere, tener viva continuamente una tensione vivificante tra le pesanti realtà della questione sociale e la visione evangelica del potere come servizio. Il vasaio deve avere le mani coperte d’argilla, deve conoscere le regole e i gesti che gli permettono di plasmare bene, ma non farà nulla che valga senza un’ispirazione superiore.
Per questo 1’attuale ricerca di un’ etica capace di delimitare e di orientare il politico esige più che mai la testimonianza e la forza della nostra fede. Certo si può, come scriveva André Glucksmann[5], abbandonarsi al meccanismo del cinismo e del sentimento. Il sentimento occidentale, secondo lui, consisterebbe nell’evitare il cinismo senza dimenticarne il messaggio, il suo obiettivo morale nel fuggire il male di cui ci si sa capaci sin dai tempi dell’Orestea di Eschilo (io aggiungerei, con René Girard, da quando la Bibbia ha osato chiamare assassinio l’uccisione di Abele…). Ma perché? Perché in definitiva preferire la morale di Kant alla contro-morale del “divin marchese” de Sade? Come smontare il nichilismo e il sarcasmo che regnano nelle nostre società? Certo solo la grazia, riconosciuta o semplicemente intuita, permette la libera e gratuita apertura all’altro, a colui che è diverso da me, e l’intuizione del mistero delle cose divenute ad un tratto delle presenze. Ispirazione spirituale, o quasi-poetica, essa convince l’individuo a intraprendere le vie della trasfigurazione e della comunione. La grazia non comanda, non organizza, ma ispira. Non si tratta di una tecnica della non-violenza, che può essere anch’essa moralmente aggressiva e farisaica: si tratta di rendere operante una forza buona venuta da altrove. Per Gandhi, per esempio, questo indù rimasto sconvolto dall’evangelo, il digiuno non era, o non tanto, un mezzo di pressione (quello che è diventato oggi), era invece un atteggiamento di preghiera, un tempo di silenzio dell’anima e del corpo, per permettere a Dio di agire nella storia. Per questo è così importante la presenza di piccole comunità monastiche ortodosse in Europa occidentale.
Il potere, l’umile potere della fede, attraverso milioni di anime, nutre la storia di eternità, fa incontrare costantemente la storia di Erode e di Pilato con la contro-storia delle Beatitudini, la “bestiale-umanità” con la “divino-umanità”. La pazienza, la sofferenza, assunte nella certezza che “questo mondo” non è il mondo di Dio; l’amore visibilmente o invisibilmente creatore che fa scaturire dalle tenebre le scintille dell’ottavo giorno, il giorno del regno; i piccoli gesti di bontà disinteressata di tanti giusti sconosciuti, ricostituiscono instancabilmente la trama dell’esistenza lacerata dalle forze del nulla. La vera storia si gioca alla frontiera del visibile e dell’invisibile. Noi la conosciamo solo in modo molto parziale. Gli angeli di luce e il “principe di questo mondo” vi intervengono, la preghiera di un bambino sconosciuto ne muta il corso, o anche la dedizione apparentemente beffarda della Matriona di cui parlava Solzenicyn, ricordando che essa era uno di quei giusti senza i quali nulla starebbe in piedi: né il loro villaggio, né la terra intera.
Il contemplativo immerso nel silenzio e ogni atteggiamento di preghiera, di apertura al mistero, provocano nella storia un’irruzione dell’eternità e permettono quelle creazioni di vita e di bellezza che, a loro volta, terranno desti i cuori. “Il suolo della storia è vulcanico”, diceva Berdjaev. Periodicamente erompono i fiumi di lava e fanno nascere nella cultura quelle immagini, quei simboli, quei thémata segreti sui quali milioni di anime fonderanno quello che Tillich chiamava “il coraggio di esistere”. Francesco d’Assisi ha reso possibile Cimabue e un primo Rinascimento nel quale l’umano si affermava senza separarsi dal divino; Sergio di Radond ha reso possibile Rublev – e non abbiamo ancora finito di contemplare l’icona della Trinità -, direi anzi: ha reso possibili Rublev e Tarkovskij.
Oggi la potenza dell’uomo sembra oggettivarsi al di fuori di lui, anzi contro di lui: in conoscenze scientifiche e creazioni tecniche che tendono a svilupparsi per mezzo del loro dinamismo interno, al punto che l’uomo non è più padrone della propria potenza, che anzi sembra dominarlo; si rischia allora quella che Michel Henry chiama la “barbarie”.
Il potere della fede susciterà un nuovo tipo di uomo capace di dominare queste forze, capace di padroneggiare la propria potenza. È necessaria qui la forza nuda dello spirito animato dallo Spirito; bisogna, nella scia della fede e della contemplazione, creare un autentico stile di umile e forte sovranità. Una nuova santità, di rottura ascetica e di trasfigurazione cosmica, permetterà con l’esempio e anche con una misteriosa trasfusione un cambiamento progressivo delle mentalità e la possibilità di una cultura che serva da mediazione tra l’evangelo e la società, tra l’evangelo e il politico.
Non si tratta, in fondo, di negare la violenza, ma di canalizzarla e di trasfigurarla, come fece la chiesa nell’alto medioevo trasformando il guerriero selvaggio in cavaliere, il capo crudele e dispotico in “santo principe”. Qui si rendono necessarie l’ascesi e l’avventura, “la lotta interiore, più dura di una battaglia tra uomini”, il gusto di servire e di creare, l’esigenza di illuminare la vita con quella bellezza “che genera ogni comunione”, come diceva Dionigi l’Areopagita.
E se il potere della morte, malgrado tutto, sembra in certi momenti, in certi luoghi, imbalsamare la storia, ridurla a una sorta di zoologia, si può ancora conservarla aperta attraverso il martirio, che costituisce la prima e fondamentale esperienza mistica del cristianesimo. Nel martirio, il potere che vuole farsi idolatrare è accettato nella sua legittimità, rifiutato nella sua pretesa totalitaria; esso permette così, suo malgrado, una testimonianza paradossale di morte-risurrezione che faceva dire agli antichi romani che i cristiani sono” quelli che non hanno paura della morte” .
Ci sono molte forme di “martirio”, banali, dissimulate, quotidiane. L’essenziale è che il cristiano sia un battezzato che ha dietro di sé la Morte (con la maiuscola), dietro di sé e non più davanti a sé, non più in sé, e che quindi non la diffonda, non la trasmetta più, ma doni e trasmetta la Vita (anch’ essa con la maiuscola). Un vivente che dia la vita, anche e soprattutto quando è oppresso dalla propria croce, anche e soprattutto quando non comprende più ma si rifugia ai piedi della croce. Un vivente che dia la vita: tale è, forse, il potere della fede.
[1] Olivier Clément, nato in Francia nel 1923, docente di teologia presso l’Institut Saint-Serge di Parigi, da anni dedica la sua vita a sondare le angosce più profonde dell’uomo contemporaneo per discernervi i gemiti latenti dello Spirito.
[2] C. Bendaly, “Le témoignage de la communauté eucharistique”, in SOP 101 (1985), p. 15.
[3] [2] F. Perroux, Pouvoir et économie, Paris 1983, p. 128.
[4] [3] C. Bruaire, La raison politique, Paris 1972, cc. 1 e 2 della prima parte.
[5] [4] Cf. Cynisme et passion, Paris 1981.


